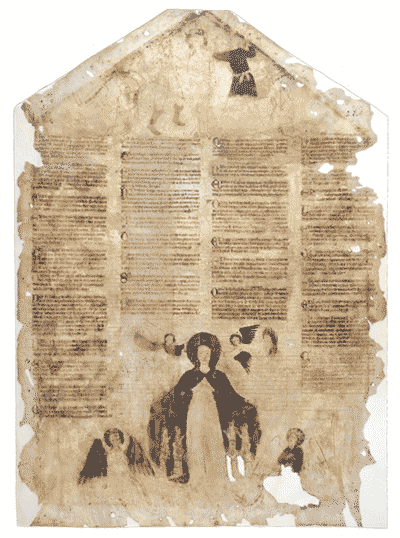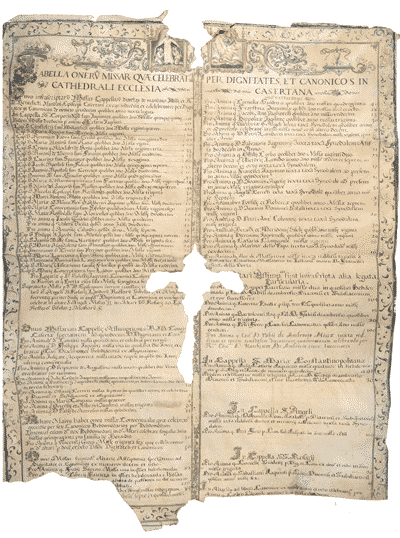LA DIOCESI DI CASERTA
«III - Età contemporanea
Dopo il periodo napoleonico il ritorno dei Borbone a Napoli quasi coincide con il misterioso omicidio del vescovo Vincenzo Rogadei (1805-1816) – successivamente sepolto in modo anonimo e frettoloso – cui non dovettero essere estranei elementi della corte di Ferdinando I e forse con l’omertà di alcuni membri del clero locale. Dopo due anni di sede vacante, alla diocesi viene unita – per effetto del concordato di Terracina del 1818 – quella di Caiazzo e fu nominato vescovo il quasi ottantenne Francesco Saverio Gualtieri (1818-1831). Sarà lui ad avanzare richiesta per la costruzione di una nuova cattedrale da realizzare in pianura dove ormai la nuova città è in pieno sviluppo. Si avvierà quindi il processo di definitivo trasferimento del capitolo e della cattedrale da Caserta vecchia – ormai scarsamente abitata e obiettivamente difficile da raggiungere per vescovo e capitolari – alla Caserta nuova, questione spinosa che sarà affrontata e risolta – non senza sofferenze e opposizioni – dal successore Domenico Narni Mancinelli (1832-1848) – guida spirituale di santa Antida Touret – con la traslazione del 2 febbraio 1842 e con la riunificazione dei due seminari in pianura. Morto il Mancinelli i moti rivoluzionari del 1848 non permisero una celere nomina da parte di Pio IX esule da Roma e ospite per quasi un anno e mezzo di Ferdinando II. Durante la sede vacante la diocesi di Caiazzo recuperò la propria autonomia e Caserta nel 1849 ebbe come nuovo vescovo Vincenzo Rozzolino (1849-1855) che si impegnò in una accurata visita pastorale e nell’abbellimento della nuova cattedrale. Egli fu costretto a trasferire l’episcopio nel centro della città, poiché la sede originaria dell’episcopio si ritrovava ormai a confinare con una piazza d’armi per esercitazioni militari; durante il lungo episcopato di Enrico de’ Rossi (1856-1894) tale sede fu, infatti, trasformata in caserma, mentre il vescovo si impegnò non poco nella edificazione di un nuovo episcopio, problema ricorrente e pressante per diversi vescovi casertani del XIX . Il de’ Rossi visse con fatica i rivolgimenti politici nazionali, costretto più volte a riparare anche per lunghi periodi a Napoli; realizzò ben otto visite pastorali, dalle quali emerge esclusivamente una attenzione all’amministrazione dei beni e un progetto pastorale di tipo devozionale. Il sinodo tenuto nel maggio del 1884 conferma l’incapacità di comprendere le novità e le emergenze dei tempi: non si fa cenno all’impellente questione sociale, alla presenza laicale e all’associazionismo cattolico. L’età avanzata e i malanni del vescovo saranno, almeno nell’ultimo decennio, una delle cause dell’ulteriore scadimento del clero diocesano, cui cercherà di porre rimedio il successore Gennaro Cosenza (1893-1913), impegnato nel potenziamento del seminario, nel far giungere in diocesi nuove famiglie religiose e nel dimostrare un ossequio, talvolta eccessivo, nei confronti delle autorità pubbliche. Tuttavia, egli non sarà in grado di adeguare la propria pastorale alle esigenze di giustizia sociale, di fronte alle quali sembra far prevalere con paternalismo una proposta di semplice rassegnazione. L’avvento della guerra caratterizzò l’episcopato del successore Mario Palladino (1913-1921), fine letterato e già vescovo di Ischia. La sua posizione – come parte dell’episcopato provinciale – sarà fortemente interventista, caratterizzata dalla promozione di iniziative a favore dei reduci e delle famiglie di caduti e dispersi; di contro non saranno pochi i sacerdoti della diocesi che cercheranno di essere dispensati dall’impegno bellico. Di particolare interesse è l’episcopato del domenicano Natale Gabriele Moriondo (1922-1943), temporalmente coincidente con il regime fascista, sul quale il vescovo e il clero casertano – quest’ultimo di fortissimi sentimenti monarchici – pur senza esprimere un’adesione piena manifestavano, tranne eccezioni, simpatia e fattiva disponibilità alla collaborazione, ispirandosi totalmente al principio d’autorità. Collaborazione che, pur motivata da sentimenti religiosi e patriottici, non venne meno né dopo i fatti del 1931 né negli anni del conflitto mondiale, conflitto giustificato in quanto promosso dall’autorità civile. In assenza dei forse dispersi carteggi del vescovo, è fonte particolarmente ricca e preziosa il «Bollettino Ufficiale» da lui personalmente curato durante tutto l’episcopato, caratterizzato dal suo infaticabile lavoro di cui sono anche prova ben quattro visite pastorali. Dall’immediato dopoguerra la diocesi avrà due episcopati di circa vent’anni ognuno, entrambi caratterizzati da un forte collateralismo nei confronti della Democrazia cristiana. Con il vescovo Bartolomeo Mangino (1946-1965) lavorarono alacremente l’Azione cattolica, i Comitati civici e sul finire degli anni Cinquanta il «Centro Studi Sociali» creato a livello nazionale dal gesuita Gliozzo e finanziato direttamente dagli Stati Uniti per la lotta contro il marxismo e il comunismo. Dallo studio delle carte di Mangino emerge però quale profondo pessimismo avesse il vescovo nei confronti di buona parte della classe dirigente democristiana dei paesi della diocesi. Il suo episcopato sarà caratterizzato da una intensa attività devozionale e di celebrazioni di ricorrenze e convegni, mentre sarà lui a inaugurare il nuovo episcopio. Con Vito Roberti (1965- 1987), precedentemente nunzio apostolico in diversi Paesi dell’Africa centrale, ma privo di concrete esperienze pastorali, la diocesi conoscerà una difficile e contraddittoria attuazione del concilio Vaticano II, mentre la collaborazione con la Democrazia cristiana aumenterà di intensità anche a motivo di presbiteri direttamente impegnati nell’agone politico. Di fronte all’avanzare della illegalità diffusa e delle attività camorristiche – causa nell’intera provincia di irreversibile distruzione ambientale provocata da cave, discariche di sostanze altamente tossiche, edilizia abusiva – la comunità ecclesiale di quegli anni appare disattenta e scarsamente impegnata, come lo sarà anche dinanzi alle endemiche questioni sociali della disoccupazione e del lavoro nero. Questo almeno fino all’autunno 1991, anno nel quale con una Lettera aperta dei cristiani di Caserta ai concittadini l’associazionismo cattolico (dall’Ac, alle Acli, all’Agesci, all’Ofs) denuncerà – ricevendo veementi attacchi dei vertici nazionali della Dc – collusioni e clientelismo della politica locale dando vita a una stagione, intensa quanto temporanea, di partecipazione e di assunzione diretta di responsabilità sociali e politiche. Nell’ambito delle emergenze artistiche nella diocesi, oltre all’antica cattedrale di Casertavecchia (XII secolo) intitolata a san Michele arcangelo – prova di un diffuso culto micaelico di cui è ricca tutta la zona – e alla cappella palatina del Palazzo reale di Caserta, sono da ricordare il monastero benedettino di San Pietro ad Montes dell’XI sec., sottoposto a un infelice restauro e di fatto non accessibile, e l’eremo di san Vitaliano – che la tradizione vuole costruito dal santo in un’epoca tra il VI e il VII . – purtroppo depredato anche di recente perfino del prezioso pavimento. Esemplari, per la spiritualità diocesana, le figure del cappuccino Francesco Mercorio da Maddaloni (1722-1807) e quella di Giacomo Gaglione (1896-1962) – per il quale è in corso la causa di beatificazione – apostolo della sofferenza e legato a san Pio da Pietrelcina. La ricerca storica sulla diocesi è oggi ostacolata dalla quasi totale assenza nell’archivio diocesano dei carteggi di molti vescovi, purtroppo dispersi molto prima che lo stesso archivio, grazie all’intervento del vescovo Raffaele Nogaro, avesse una degna sistemazione. Un vuoto grave e forse incolmabile che priva gli storici di fonti documentarie di importanza primaria e che rende impossibile, per il momento, lo sviluppo di ricerche complessive sulla diocesi.