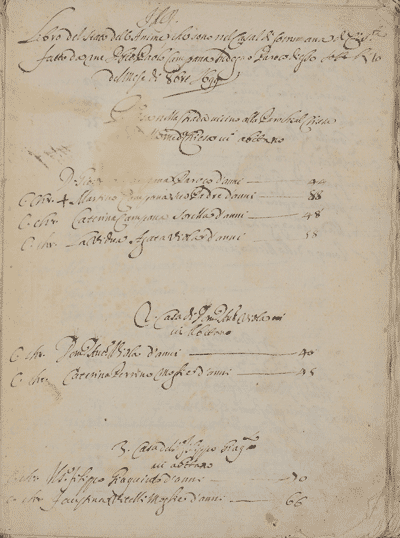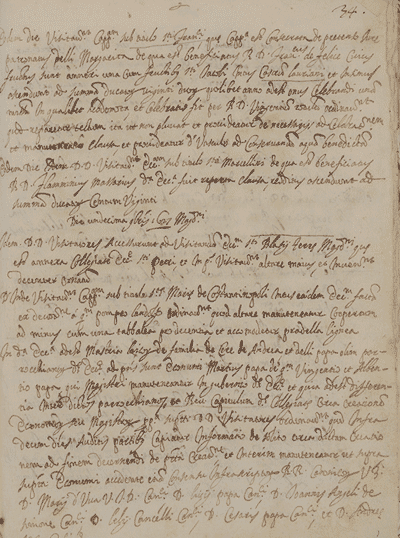LA DIOCESI DI CASERTA
«I - Età medioevale
Sorta in seguito al trasferimento del titolo episcopale di Calatia – la città romana situata a ovest di Maddaloni – la diocesi di Caserta era sicuramente già esistente da alcuni anni quando, nel 1113, l’arcivescovo di Capua Sennete (1097- 1118) ne confermò al vescovo Rainulfo (1113-1129) la circoscrizione ecclesiastica. La nuova diocesi nasceva come estensione della originaria diocesi di Calatia al territorio della importante contea di Caserta, il cui signore, il normanno Roberto I di Capua, nel 1119 concesse agli uomini del vescovo casertano il diritto di abitazione, pascolo e taglio dei boschi nelle terre calatine, circostanza confermata dall’espressione Casertana seu Calatina Ecclesia, presente in un atto ufficiale del vescovo Giovanni (1137-1165). La bolla di Sennete indicava con precisione i confini della diocesi suffraganea di Caserta che erano costituiti a nord dal corso del fiume Volturno; a est dal torrente Biferchia, dal rio del colle Cerqua Cupa e dal monte Longano; a sud dall’alveo acquitrinoso del fiume Clanio (area denominata successivamente, a partire dalla bonifica del periodo spagnolo, «Regi Lagni»); e a ovest dal monte Cupo. Il nuovo disegno dei confini, che in taluni casi divideva in due, con discutibili linee di demarcazione, terre e comunità di precedente giurisdizione capuana, e le caratteristiche del territorio, su cui venne a insistere la nascente diocesi, furono causa di numerosi conflitti di competenza e contrasti con i metropoliti di Capua, i quali mostrarono, nel tempo, una costante volontà di difendere le loro prerogative, riuscendo, in tutti i casi, a evitare che si verificassero modifiche rilevanti a vantaggio di Caserta. Per questi motivi i confini della diocesi di Caserta rimasero da quel momento pressoché invariati. Se il territorio della diocesi non subì nei secoli successivi modifiche di rilievo, il patrimonio della Chiesa di Caserta ebbe, già a partire dal XII sec., un notevole incremento, grazie al gran numero di donazioni e alle numerose concessioni di diritti attribuiti a vario titolo ai vescovi dai feudatari di Caserta e confermati successivamente a più riprese dalla corona. Sicuramente un ruolo molto importante nella crescita di prestigio della Ecclesia casertana ebbe l’edificazione, agli inizi del XII sec., della cattedrale, di impronta desideriana, dedicata al culto di San Michele arcangelo, e del connesso complesso monumentale costituito dall’episcopio e dal seminario, cui si sarebbero aggiunti, successivamente, il campanile e la chiesa dell’Annunziata con l’ospedale. La realizzazione della nuova sede vescovile coincise con una fase di forte slancio della vita della diocesi, protrattasi per tutto il XII sec., frutto di un rinnovato fervore spirituale, innescato dalla riforma voluta dall’abate Desiderio, che si tradusse in uno straordinario sviluppo dell’edilizia religiosa con la costruzione di numerose chiese, cappelle e conventi in tutto il territorio diocesano. Gli importanti privilegi attribuiti ai vescovi di Caserta, tra i quali la riscossione di tributi e delle decime – confermate dal re Carlo d’Angiò nel 1270 al vescovo Filippo dei Minori – nonché l’amministrazione della giustizia civile, insieme con l’accresciuto prestigio acquisito, consentirono ai vescovi di Caserta di esercitare una influenza forte e capillare sulle popolazioni della città e del contado, i cui legami di fedeltà e devozione alla cattedra di Caserta divennero con il tempo sempre più solidi ed estesi. Nel XIV, la diocesi risultava divisa in cinque arcipreture, corrispondenti, rispettivamente, alla cintura dei monti Tifatini, alla pianura campana, a quella sottostante al tenimento di Limatola, all’area di Castel Morrone e a quella prospiciente il monte Longano (Maddaloni). Proprio le importanti prerogative di governo e i diritti fiscali che i presuli casertani poterono vantare sin dalle origini costituirono motivo di aspra contesa con la riottosa e, spesso, violenta feudalità locale, la quale, oltre a non pagare le decime dovute, compiva continui soprusi ai danni degli uomini della Chiesa. Così, il vescovo Azzone (1287-1310) fu costretto ad affrontare una dura contesa con i signorotti casertani per difendere le sue prerogative dalle loro prepotenze, riuscendo, alla fine, a ottenere dal re un atto (1303) con il quale si confermavano solennemente tutte le decime sui beni burghensatici e demaniali di Caserta, Morrone, Limatola, Ducenta e Maddaloni. Pochi anni dopo il vescovo Benvenuto da Milo arrivò a scomunicare il conte Francesco della Ratta (la scomunica venne poi ritirata in seguito a una transazione stipulata nel 1327) per aver questi abusato di uomini e beni ecclesiastici ed essersi rifiutato di versare le decime. Nella contesa tra la curia vescovile e il potere comitale i sovrani di Napoli tesero, nella maggior parte dei casi, a sostenere le ragioni della Chiesa locale – a patto che questa si mantenesse a loro fedele – anche per porre un argine al crescente potere della nobiltà, pericoloso per la corona. Nel corso del XV, il centro medievale di Caserta perse progressivamente e definitivamente la sua importanza come principale punto di riferimento e di incontro per le popolazioni, mentre crescevano i nuovi insediamenti nella parte pedemontana e pianeggiante del territorio della diocesi. Il trasferimento della sede comitale a valle (1483) e lo sviluppo del Villaggio Torre (primo nucleo della futura Caserta) segnano, anche simbolicamente, la fine di un periodo e il passaggio alla successiva età moderna.